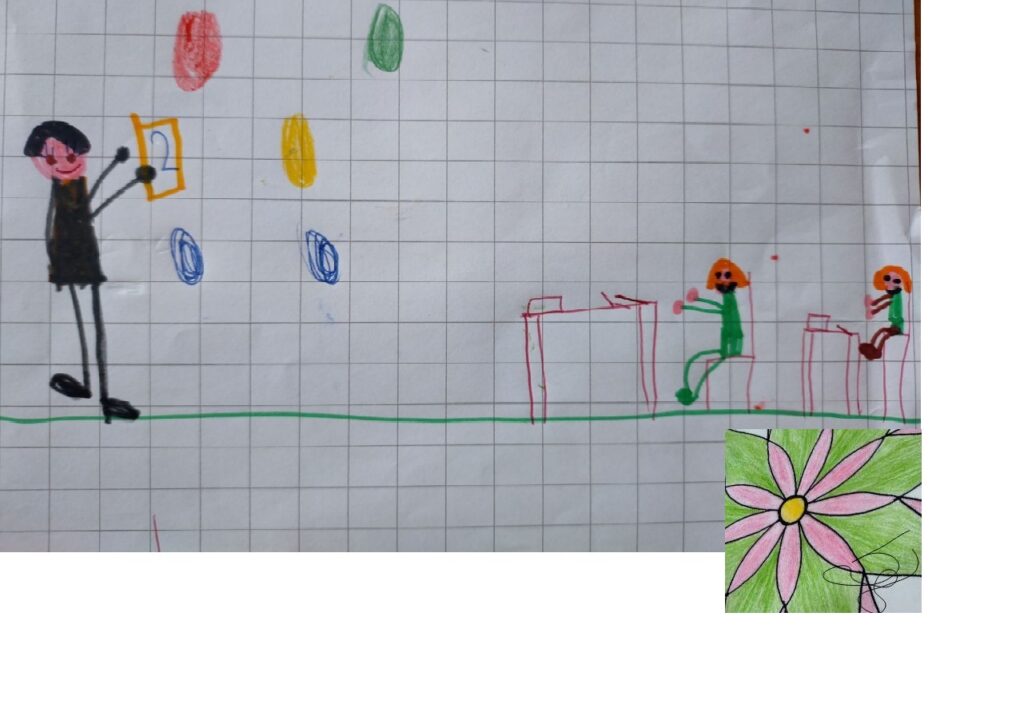Oggi quando si parla di educare, si fa spesso riferimento a situazioni in cui i bambini vengono invitati a essere “bravi”, se non lo sono vengono corretti. Ciò ha ridotto l’Educare a un pragmatismo personalistico talvolta anche discutibile, ovvero quello di ottenere dal bambino ciò che viene ritenuto consono, giusto, appropriato in una data situazione piuttosto che in un’altra, provocando nella società in generale una sorta di “pedagogia del fai da te” che non ha nulla a che vedere con quel “tirar fuori” che intendevano gli antichi. A ciò detto penso spesso anche alla fiaba del burattino Pinocchio di Carlo Collodi che, “intrappolato” nel pezzo di legno di ciliegio, Geppetto un giorno cercò di tirare fuori, ex-ducĕre, pensando e provando ad educarlo fino a farlo divenire un bambino vero.
Questa svalutazione della Pedagogia, che era a fondamento di ciascuna società passata e che si fondava sul valore più alto dell’educare, era legata al perseguimento della formazione del cittadino nella Paideia. Quest’ultima si riferiva al concetto occidentale di cultura intesa come formazione globale dell’individuo dove la virtù veniva veicolata dal sapere. Dunque il termine Paideia di origine greca, significava appunto “educazione”, “formazione” nel senso di trasmissione di conoscenze e valori, che innalzavano il cittadino della Polis per farlo divenire uomo giusto ed equo, capace di vivere in pace e amore con gli altri. In questo senso il valore etico e morale dell’educazione non viene ad essere un modo per ottenere un consenso momentaneo sul comportamento da tenere in determinate situazioni, ma viene a porsi come modello di trasmissione e condivisione di cultura a tutti i livelli, da quello spirituale a quello artistico, dalla cura del corpo al rispetto degli altri, dalle conoscenze di base a quelle specialistiche, incarnati da uomini e donne capaci di tramandare i valori condivisi di una società basata su ideali di giustizia, di fratellanza, di solidarietà, di uguaglianza e rispetto delle diversità, che poi sono i valori fondanti e irrinunciabili di una civiltà che si definisca tale. Ecco allora che quel “tirar fuori” di antica memoria, non significava riempimento temporaneo della mente ma si fondava sull’assunto che l’adulto era come una guida che aiutava il bambino a tirare fuori ciò che ancora non era, con l’insegnamento continuo di saperi, regole, leggi, valori etici e morali condivisi e ripetibili nella società.
Educare nella società occidentale contemporanea è diventato molto difficile a diversi livelli della struttura sociale. La famiglia tende a delegare spesso agli “altri” il proprio ruolo, anche se il centro di prima formazione del bambino è proprio lei: la famiglia, quale agenzia formativa primaria. Assistiamo spesso impotenti a situazioni in cui è il bambino a “decidere” per sé stesso sostenuto da genitori incapaci di mantenere una linea educativa anche solo con l’esempio, addirittura assecondando tutte le “inclinazioni” naturali dei figli certi di fare il loro bene per sentirsi buoni genitori. Ma la dialettica non deve essere tra il bisogno di sentirsi bravi genitori per i figli e il non esserlo, ma cercare di essere educatori in tutte le fasi di crescita di questi, creando dei modelli di riferimento solidi più che essere visti come “amici” con cui confrontarsi alla pari. Riflettere e scegliere un’educazione migliore per i propri figli significa mettersi in discussone, affrontare i problemi con maturità e consapevolezza, significa fare un progetto a lunga scadenza, che comincia nel momento in cui egli nasce e che dura fino all’età adulta, quest’ultima intesa come conclusione di un percorso di studi e intrapresa di un lavoro che renda autonomi.
D’altro canto anche le Istituzioni Educative sono in crisi. A fronte di molte richieste, sia dall’interno che dall’esterno, l’educatrice si trova spesso suo malgrado, sotto i riflettori, per avere o non aver saputo gestire bambini “non educati” o “educati male”. Spesso manca il coraggio di esternare l’approccio educativo ma anche il piano pedagogico che si persegue, la comunicazione verso l’esterno diventa difficile perché fatta con tutti i mezzi o in tutti i luoghi tranne che con le parole o in stanze adeguatamente adibite all’accoglienza. Spesso anche le parole usate, il tono, la gestualità, la mimica facciale e il contenuto in una conversazione tra educatore e familiare risultano poco empatici e talvolta contraddittori, spesso si tratta di una comunicazione dove si danno giudizi o si fanno diagnosi piuttosto esplicite e tutto ciò porta inevitabilmente alla creazione di incomprensioni e discussioni tra la famiglia e l’ente educativo. Se un tempo ciò che veniva detto al genitore aveva delle ripercussioni a casa sul figlio, adesso si ritorce contro l’educatore. Quanto detto vale per ogni contesto educativo ma sembra che di questo stato delle cose si stia accorgendo anche la società civile, alle prese ormai con ragazzi o giovani adulti che non sanno “comportarsi” in modo educato e rispettoso dell’altro e che addirittura trovano nei genitori spalle su cui affidarsi per venire fuori dai problemi creati da essi stessi.
Il terzo livello dell’educare spetta sicuramente alla società civile che fa capo a uno Stato. In tutti i Paesi dell’area occidentale vengono emanate leggi con obblighi e diritti all’istruzione e all’educazione, tuttavia, spesso si assiste alla disattenzione da parte degli uomini delle Istituzioni verso il valore pedagogico di ciò che dicono o ciò che fanno. In altre parole “si predica bene e si razzola male”, chi deve dare l’esempio di onestà e buon cittadino e soprattutto usare un linguaggio adeguato alle vesti che porta, spesso si comporta senza pensare alle conseguenze delle sue azioni o delle sue parole. Invece l’uomo o la donna della Res Pubblica deve essere come un “fanale” che illumina nella notte oscura, per questo parole e comportamenti devono essere all’altezza delle sue funzioni e delle leggi che emana. La società civile parimenti, con le sue associazioni, i suoi enti, e tutti i cittadini in qualche modo attivi e al servizio della comunità che scelgono di far crescere positivamente, hanno un peso enorme nell’educare il cittadino. Tuttavia è proprio dalla società civile che vengono lanciati gli allarmi più preoccupanti, dunque cosa bisogna fare? A mio avviso bisogna avere il coraggio di Educare in qualsiasi ruolo ci presentiamo, bisogna avere il coraggio di ristabilire valori condivisi, regole accettate e accettabili da tutti, bisogna cambiare anche il modo di comunicare e affermare i punti fermi e imprescindibili sui quali si intende lavorare in modo sereno ma deciso.
Chiudo con un’immagine molto bella sull’educazione intesa come la necessità di dare al bambino alcuni punti di riferimento morali e soprattutto comportamentali che rappresentano delle “briccole” o dei fari che possano guidarlo nelle situazioni più complesse per arrivare al porto, ma anche di poter ripartire per nuove esperienze di vita, sempre più forti e sempre più consapevoli di sé stessi (Trisciuzzi Leonardo “Elogio dell’educazione”).